
Report
on the Cambridge conference on “immaterial labour, multitudes
and new social subjects: class composition in cognitive capitalism”
Emiliana Armano
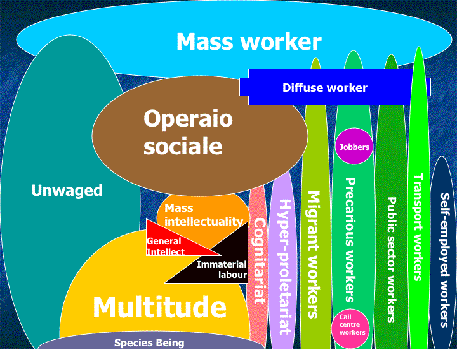
Da mesi correvano nelle liste i messaggi su questo appuntamento. Preparato e coordinato da Ed Emery -una figura di intellettuale felicemente outsider perno della Universitas Adversitatis (“a peripatetic free university”) collegata a esperienze quali i seminari di Uninomade e Samizdat- il Convegno di Cambridge si è tenuto il 29 e 30 aprile sul tema Immaterial labour, multitudes and new social subjects: class composition in cognitive capitalism (per interventi e abstracts vedere qui). La conference è stata poi di fatto anticipata di un giorno con la sessione dedicata al significato della recente mobilitazione francese.
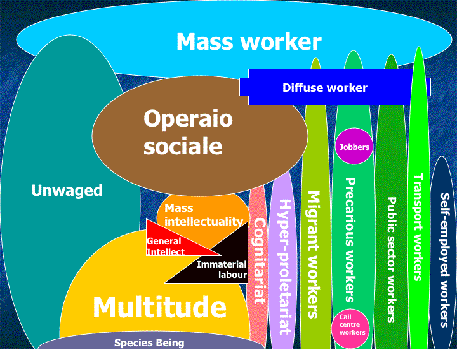
Una delle 'mappe' portate da Steve Wright alla discussione durante il convegno
Nella
“lecture” della prima serata, nella sala del King’s
College, Andrea Fumagalli partendo dal passaggio di fase segnato del capitalismo
cognitivo ha posto la proposta di basic income al centro di una vivace
discussione che è proseguita per tutta la tre giorni, anche nei
momenti informali tra un intervento e l’altro. Questo primo focus
del convegno si è intersecato con la rilettura dei percorsi dell’operaismo
o, con un termine anglo-sassone in un’accezione però più
ampia, dell’autonomist marxism.
Steve Wright -autore di Storming Heaven, un saggio storico di ricostruzione dei complessi percorsi dell’operaismo italiano, non ancora tradotto da noi ma ben noto alla sinistra anglo-sassone e tedesca- ha ripercorso le basi teoriche delle intuizioni politiche e delle ricerche di `intellettuali-militanti' come Romano Alquati, Raniero Panzieri, Sergio Bologna, Mario Tronti, Toni Negri. La sua mappa illustrativa dell’ “albero genealogico operaista” ha reso anche visivamente evidente il passaggio nella composizione di classe dall’operaio massa all’operaio sociale fino alla moltitudine. Ma in che senso ci si può riferire oggi alla nozione di composizione di classe? E come si declina il passaggio dal livello tecnico a quello politico? Queste meta-domande sono riaffiorate in continuazione nel convegno. L’intervento di Yann Moulier Boutang ha portato una riflessione sulla nuova “grande trasformazione” in atto provando a incrociarla con l’emergere delle istanze di moltitudin-i e soggettività eterogenee lasciate in disparte dalle teorie workerist degli anni ’60 e ’70.
Il concetto di lavoro immateriale per un verso è sembrato alludere all’emergere di un nuovo soggetto, per un altro è servito a mettere in evidenza le diverse forme che esso assume. Sia negli aspetti di ulteriore sussunzione ai meccanismi di mercificazione sia nei suoi risvolti antagonistici. Così, gli interventi hanno spaziato dalla mediatizzazione delle relazioni sociali al ruolo del mediattivismo: Harry Halpin -autore del libro Shut Them Down: the G8, Gleneagles and the movement of movements del network Dissent!- si e’ soffermato sulla “sovranità digitale”. Dalla produzione peer to peer alla costruzione di controreti nell’intervento di Michel Bauwens, creatore della Foundation for P2P Alternatives.
Massimo De Angelis con David Harvie, della rivista online Commoners, ha dato una lettura “bravermaniana” del lavoro immateriale, incentrandosi non tanto sull’emergere dell’intellettualizzazione delle attività quanto sull’estendersi di fenomeni di industrializzazione nell’attività formativa della ricerca e nelle università. Di qui il continuo tentativo di misurazione della produttività che caratterizza anche il capitalismo cognitivo. E’ così riemerso il nodo del rapporto con i processi di astrattizzazione del lavoro, che in questa lettura però rischiano di essere letti prevalentemente in termini di semplificazione delle attività.
In generale, dai diversi contributi è emerso che per afferrare i significati del lavoro immateriale si tratta di orientare lo sguardo alla costruzione delle soggettività sull’intero spettro della vita. Ne ha dato una declinazione particolare ma efficace Ed Emery che ha descritto la produzione delle merci securitarie in quello stato di eccezione permanente che è diventato il conflitto in Palestina. Produzione di soggettività anche, se è vero che la “paura” diventa normale modalità di vita nelle società occidentali e la sua produzione essenziale per alimentare la sindrome sicuritaria. Si è così aperta una finestra sul tema guerra globale che il convegno aveva un po’ trascurato.
Un provvisorio quadro d’insieme su questa prima parte l’ha fornito il contributo sui commons proposto da Nick Dyer-Witheford (autore di CyberMarx) che ha cercato di tenere insieme il discorso sulla circolazione dei “beni comuni” con quello sulla circolazione delle lotte, comprendendo le battaglie sulle risorse ambientali, sul welfare, sulle reti, dal Sud al Nord. Non a caso, si è dimostrato interessato ad un cd autoprodotto, con sottotitoli in inglese, sulla lotta NoTav che girava in sala.
Il secondo focus
del convegno, dopo l’analisi, è stato dunque quello della
proposta politica su cui si è incentrata la sessione finale dedicata
al basic income. Toru Yamamori, giovane ricercatore giapponese, ha delineato
il panorama internazionale delle lotte che in forme diverse ruotano intorno
a questa rivendicazione. Carlo Vercellone, attento ai possibili fraintendimenti
teorici della questione, l’ha poi collegata strettamente alla fine
della regolazione fordista: la crisi del compromesso sociale tra lavoro
e capitale basato sulla redistribuzione ha aperto alla precarieta’
come sistema di controllo sociale ed è a questa situazione che
è necessario sottrarsi. Andrea Fumagalli ha argomentato come l’attuale
economia di mercato si basi su un’eccedenza di lavoro sociale non
riconosciuto che si realizza nei nostri tempi di vita indistinti dai tempi
del lavoro e funzionali alla riproduzione del capitale. La produttività
sociale insita nelle relazioni sociali in quanto tali è in grado
di remunerare il reddito di esistenza, non come misura assistenziale o
compensazione diretta di attività specifiche, ma come diritto incondizionato
svincolato dal lavoro in senso stretto. Questo è il tema che ha
suscitato più discussione. (Non solo a Cambridge del resto, ma
anche nel seminario tenutosi qualche giorno dopo a Leicester: vedi qui).
Da un lato, ha destato perplessità l’idea che l’adozione
di una misura di questo tipo produrrebbe una spinta keynesiana alla domanda,
funzionale quindi agli equilibri capitalistici. Ma al di là delle
critiche semplicemente ideologiche la proposta è stata discussa
in relazione alla concreta esperienza delle politiche di sostegno al reddito
in paesi di welfare “nordico” come il Regno Unito e la Germania.
Lì parlare di basic income probabilmente evoca le misure centralistico-statali
dei governi socialdemocratici in un quadro opposto a ogni possibile autonomia,
per intenderci in situazioni da film di Ken Loach! In questo senso si
misura una differenza che in Europa si dà effettivamente, sia sul
piano delle istituzioni welfaristiche sia nella soggettività precaria.
Su questi aspetti abbiamo posto alcune domande ad Andrea Fumagalli.
Nel Convegno di Cambridge il discorso sul basic income ha catalizzato l’ interesse dei partecipanti, è stato proprio in quella sessione che è emersa la proposta politica del convegno. Nella discussione le critiche si sono incentrate su vari aspetti. Come le vedi?
Vi sono due ordini di critiche all’ipotesi del basic income, all’interno della sinistra cd. “radical”. Il primo è solitamente fatto dai gruppi che si ritengono più puramente rivoluzionari e “dogmatici” e considerano la proposta di basic income troppo riformista e compromissoria, alla Kautsky per intenderci, con il rischio di distogliere la classe lavoratrice dal vero obiettivo di capovolgere i rapporti di sfruttamento tipici dell’economia capitalistica. Anzi, l’ottenimento di un basic income avrebbe lo scopo di “ammorbidire” la potenza rivoluzionaria della “classe”, imborghesendola. Al riguardo, vorrei sottolineare che tale dialettica si era riproposta in termini analoghi nell’autunno caldo quando i gruppuscoli più dogmaticamente emme-elle criticavano la parola d’ordine “aumenti salariali uguali per tutti” più o meno con le stesse argomentazioni. La storia ci ha insegnato che tale richiesta ha aperto la porta ad ulteriori richieste che hanno messo in crisi l’organizzazione e la divisione capitalistica del lavoro sino a favorire un suo superamento. Il secondo ordine di critica vede la proposta di basic income come un puro enunciato politico (una “parola d’ordine”) a cui non segue una capacità di mobilitazione. Tale questione è sicuramente più importante e coglie in effetti un aspetto di criticità, anche se negli ultimi anni si sono fatti passi in avanti. Il punto centrale è l’individuazione delle controparti sociali e la definizione dell’ambito territoriale del conflitto al fine di creare i presupposti per la nascita e lo sviluppo di una vertenza sociali sul tema del reddito.
Di cosa sono espressione queste perplessità dal punto di vista della realtà sociale europea? Confrontando la discussione sulla proposta del basic income in UK e quella nei movimenti, ma non solo, in Italia come valuti le differenze nei percorsi che si vanno sviluppando, alla luce anche dell’esperienza dell’ EuroMayDay?
Le differenziazioni sociali e territoriali in Europa sono elevatissime, così come le esperienze di policy e governance che il welfare europeo ha sperimentato. E’ evidente che nei paesi del Nord e del continente centrale europeo, si sono sperimentate già da tempo politiche di sostegno al reddito, a differenza dei paesi mediterranei (ad oggi, solo Grecia e Italia non hanno mai sperimentato tali politiche). Esse si sono sviluppate all’interno di un’ottica fordista-keynesiana di stampo assistenziale e in questi paesi, soprattutto in UK, il sostegno al reddito è visto come misura esclusivamente di natura assistenziale. In realtà, in un ambito di capitalismo cognitivo, il basic income, lungi dall’essere misura assistenziale, è invece attività di remunerazione della vita come fattore produttivo messo a valore costantemente. Da questo punto di vista, la lotta per il basic income equivale oggi alla rivendicazione degli operai massa al tempo del taylorismo di incrementi salariali superiori alla produttività. E, come allora, anche oggi le rivendicazioni di reddito si coniugano con altre rivendicazioni legate all’organizzazione del lavoro: all’interno del processo EuroMayDay, non a caso, si parla di un pacchetto di misure e richieste che va sotto il nome di flexicurity, ovvero, garanzia di reddito diretto e indiretto in modo incondizionato e su base individuale, salario minimo orario, riduzione delle tipologie contrattuali atipiche, diritti sindacali uguali e prescindere dal contratto di lavoro. Non è un caso che oggi precarietà e nuovo welfare, ovvero reddito, siano i punti nevralgici dell’odierno e futuro conflitto sociale in Europa come gli avvenimenti in Francia di questa primavera e in Danimarca di questi giorni ben evidenziano. Tuttavia, occorre tenere conto che la percezione di questi aspetti è ancora molto diversificata, ma, inevitabilmente, il movimento del precariato europeo sarà costretto ad unificarsi. Quando ciò avverrà dipenderà anche dalla differenza di linguaggio che tuttora persiste
Quali passi avanti ha fatto fare il convegno di Cambridge e quali limiti ci sono stati? Si è trattato di un confronto in qualche modo non solo tra aree ma anche tra “intellettuali” di movimento e attivisti?
Il Convegno di Cambridge è stato molto importante e utile perché per la prima volta in modo organico e con tempo sufficiente si sono confrontate opzioni politiche e analitiche diverse, seppur entrambe impegnati nei movimenti sociali post-Seattle. Per noi italiani e francesi della scuola neo-operaista (penso a Moulier Boutang, Vercellone) è stata l’occasione per introdurre la proposta di basic income nel dibattito anglosassone. Se c’è stato un limite è che forse c’era troppa carne al fuoco: gli stimoli delle relazioni erano tanti e forse vi è stato insufficienza di tempo per un dibattito che avrebbe potuto essere ancor più approfondito. Di positivo, c’è stato il confronto tra diverse soggettività della militanza sociale, in particolare tra chi opera concretamente sul territorio e chi svolge analisi su un piano più teorico.
I nuovi movimenti di lotta hanno una natura sociale tendenzialmente autonoma di auto-rappresentazione o passano ancora tramite la elaborazione degli “attivisti politici e sindacali”
I movimenti di lotta più innovativi sul piano della comunic/azione e dell’agitazione creativa sono intrinsecamente autonomi. Al limite sono poi i gruppi organizzati dei partiti e dei sindacati a mettersi a ruota e a inseguirli. L’esempio dell’EuroMayDay parla da solo. Occorre anche considerare che oggi le forme organizzative, grazie alla rete informatica, tendono ad assumere forme più orizzontali e meno verticali, con un ruolo meno rilevante di ciò che un tempo erano i partiti o le avanguardie. La stessa struttura verticistica sindacale non consente forme di auto-rappresentazione delle soggettività come la stessa rete è in grado di fare.
Leicester, 4 maggio 2006
